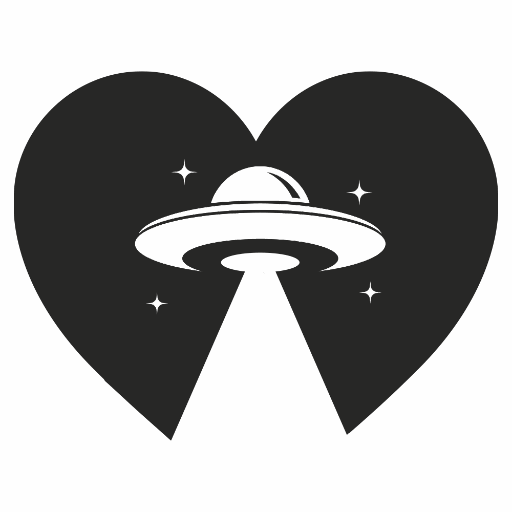Una nuova teoria suggerisce che le civiltà extraterrestri esistono ma sono bloccate allo stesso livello tecnologico: dopo qualche tentativo di esplorazione, si stancano e rinunciano
Hai mai alzato lo sguardo verso il cielo notturno e ti sei chiesto: “Ma dove sono tutti quanti?” Non parlo dei tuoi amici che non rispondono ai messaggi, ma degli alieni. Sì, proprio loro: gli extraterrestri, le civiltà avanzate, i vicini cosmici che, secondo le statistiche, dovrebbero essere là fuori da qualche parte.
Pensaci un attimo: l’Universo pullula di miliardi di galassie, ognuna contenente miliardi di stelle e intorno a quelle stelle orbitano innumerevoli pianeti. È un numero talmente vasto che fa girare la testa solo a pensarci. Eppure, nonostante questa abbondanza cosmica, noi esseri umani siamo qui, completamente soli, circondati da un silenzio assordante. Nessun segnale radio misterioso, nessuna nave spaziale che sorvola Times Square, nessun “Ciao, ci siamo anche noi!” proveniente dalle profondità dello spazio.

Questo enigma ha un nome preciso: il paradosso di Fermi. E fidati, ha fatto perdere il sonno a generazioni di scienziati, filosofi e appassionati di fantascienza.
Il paradosso che ci tormenta da decenni
Il paradosso prende il nome dal fisico Enrico Fermi che, durante una pausa pranzo nel 1950, pose ai colleghi una domanda apparentemente semplice ma profondamente inquietante: “Dove sono tutti?” La sua logica era ineccepibile. Se consideriamo l’età dell’Universo (circa 13,8 miliardi di anni) e il numero astronomico di stelle e pianeti potenzialmente abitabili, dovrebbero esistere civiltà extraterrestri molto più antiche e tecnologicamente avanzate della nostra. Anche solo una frazione infinitesimale di pianeti che sviluppa vita intelligente dovrebbe tradursi in migliaia, se non milioni, di civiltà sparse per la galassia.
E se alcune di queste civiltà sono anche solo un paio di milioni di anni più vecchie di noi (un battito di ciglia in termini cosmici), avrebbero avuto tutto il tempo per colonizzare l’intera Via Lattea, o quantomeno per lasciarci un biglietto da visita sotto forma di segnale radio o sonda spaziale.
Invece? Nada. Niente di niente. Il grande vuoto cosmico.

Nel corso dei decenni, sono state proposte decine di spiegazioni per questo silenzio cosmico. Alcune sono ottimiste: forse gli alieni ci osservano rispettosamente da lontano, tipo uno zoo cosmico, aspettando che maturiamo abbastanza prima di presentarsi. Altre sono decisamente più cupe: magari le civiltà avanzate si autodistruggono inevitabilmente, o forse c’è un “Grande Filtro” evolutivo che impedisce alla vita di superare un certo stadio di sviluppo.
La nuova teoria: gli alieni sono banali come noi
Ed ecco che arriva una nuova ipotesi, fresca di stampa (o meglio, di arXiv, il repository dove gli scienziati pubblicano i loro studi in attesa di revisione). Robin Corbet, uno scienziato del Goddard Space Flight Center della NASA che lavora presso l’Università del Maryland, ha proposto una spiegazione che è al tempo stesso deludente e stranamente rassicurante.
La sua idea? Gli alieni esistono, ma sono fondamentalmente… normali. Banali. Ordinari. Proprio come noi.

Secondo Corbet, eventuali civiltà extraterrestri sparse per la galassia non hanno raggiunto chissà quali livelli di sviluppo tecnologico fantascientifico. Non viaggiano più veloci della luce, non sfruttano l’energia oscura o la materia oscura, non hanno costruito megastrutture spaziali tipo la Sfera di Dyson per catturare tutta l’energia della loro stella. Non stanno nemmeno sfruttando leggi della fisica sconosciute a noi.
In altre parole: non sono gli onnipotenti Antichi di Stargate, né i Borg di Star Trek, né tantomeno i mistici Protoss di StarCraft. Sono più simili a… beh, a noi. Con telefoni magari un po’ più fighi (pensa a un iPhone 42 invece del tuo iPhone 17), ma sostanzialmente allo stesso livello tecnologico.
Corbet ha dato un nome evocativo a questa teoria: il principio della “monotonia radicale” (radical mundanity). Un termine che suona quasi come una provocazione: dopo decenni passati a immaginare civiltà stellari capaci di piegare lo spazio-tempo come un origami, ci viene detto che gli alieni sono probabilmente noiosi quasi quanto noi.
Il tetto tecnologico: quando smetti di progredire
Ma cosa significa esattamente questa “monotonia radicale”? L’idea di base è che esista una sorta di plateau tecnologico: un livello oltre il quale è tremendamente difficile, se non impossibile, progredire. Pensala come un muro invisibile che tutte le civiltà, terrestri o extraterrestri che siano, finiscono per sbattere contro.
Guarda la nostra storia recente. Negli anni ’60 e ’70 eravamo euforici: avevamo conquistato la Luna, volavamo con aerei supersonici, pensavamo che entro il 2000 avremmo avuto colonie su Marte e città orbitanti nello spazio. Poi cosa è successo? Ci siamo fermati. Anzi, in certi ambiti siamo persino regrediti: non andiamo più sulla Luna da oltre cinquant’anni, il Concorde è stato ritirato dal servizio, e la maggior parte delle nostre innovazioni recenti riguarda come rendere i telefoni più sottili di un millimetro.

Certo, abbiamo fatto progressi incredibili in informatica, biotecnologie, intelligenza artificiale. Ma per quanto riguarda l’esplorazione spaziale e la fisica fondamentale? Siamo sostanzialmente fermi da decenni. Le leggi della fisica che conosciamo sembrano porre limiti invalicabili: niente viaggi più veloci della luce, niente energia infinita, niente scorciatoie attraverso lo spazio-tempo.
Corbet suggerisce che questo potrebbe essere un destino universale. Forse ogni civiltà, dopo un periodo iniziale di rapido progresso tecnologico, raggiunge questo stesso muro e si ferma. E dopo essersi fermata, dopo aver realizzato che le stelle più vicine sono comunque maledettamente lontane e che i viaggi interstellari richiedono risorse e tempo impensabili, semplicemente… si stanca.
La stanchezza cosmica: quando smetti di cercare
Ed eccoci al punto più interessante (e forse più deprimente) della teoria di Corbet: dopo un po’, gli alieni semplicemente smettono di cercare.
Immagina di essere una civiltà aliena su un pianeta a 50 anni luce dalla Terra. Hai sviluppato la tecnologia per costruire radiotelescopi potenti, magari hai anche mandato qualche sonda robotica verso i sistemi stellari più vicini. Ascolti il cosmo per anni, decenni, secoli. Silenzio totale. Le sonde che hai lanciato impiegheranno migliaia di anni per raggiungere la destinazione e anche se trovassero qualcosa passeranno altri migliaia di anni prima che tu riceva notizie.
A un certo punto, ti fai una domanda legittima: “Ma ne vale davvero la pena?”

Mantenere potenti laser cosmici accesi per milioni di anni nella speranza che qualcuno li noti richiede risorse enormi. Continuare a investire in programmi spaziali quando i risultati potrebbero arrivare tra diecimila anni (se va bene) diventa politicamente ed economicamente insostenibile. E così, gradualmente, abbandoni la ricerca. Ti concentri su problemi più immediati, più tangibili, più risolvibili nell’arco della tua vita o di quella dei tuoi figli.
Riconosci questo schema? Dovresti, perché è esattamente quello che abbiamo fatto noi. Dopo l’entusiasmo dell’era Apollo, i budget della NASA sono stati tagliati drasticamente. I programmi spaziali ambiziosi sono stati accantonati in favore di progetti più “pratici”. Il progetto SETI, dedicato alla ricerca di segnali extraterrestri, sopravvive principalmente grazie a finanziamenti privati e donazioni.
Non è che abbiamo smesso di essere curiosi o di sognare le stelle. È che, di fronte alla vastità dello spazio e alla lentezza dei progressi, abbiamo deciso di concentrarci su orizzonti più piccoli, più gestibili. Su quello che possiamo effettivamente raggiungere nell’arco di poche generazioni.
Perché questa teoria è rassicurante (ma anche un po’ triste)
C’è qualcosa di stranamente confortante in questa idea della monotonia radicale. Significa che, se là fuori ci sono altre civiltà, probabilmente stanno affrontando le stesse sfide che affrontiamo noi. Gli stessi limiti fisici, gli stessi problemi di risorse, gli stessi dilemmi su dove investire tempo ed energie.

Non siamo soli nella nostra “mediocrità” cosmica. E soprattutto, non dobbiamo preoccuparci di scenari apocalittici: niente invasioni aliene con tecnologie incomprensibili, niente civiltà predatorie che ci vedono come formiche da schiacciare, niente grigi che ci rapiscono per esperimenti bizzarri.
Se Corbet ha ragione, un eventuale primo contatto con gli alieni sarebbe probabilmente… deludente. Immagina di ricevere finalmente un segnale dopo decenni di ricerca, di decifrarlo con trepidazione, e di scoprire che il messaggio dice sostanzialmente: “Ehi, ci siamo anche noi. La vita fa un po’ schifo anche qui. Siamo bloccati sul nostro pianeta come voi. Che ne dici, vuoi scambiarci ricette o qualcosa del genere? Ci vediamo tra qualche migliaio di anni, forse.”
Non esattamente l’epica rivelazione cosmica che ci aspettavamo, vero?
Allo stesso tempo, c’è qualcosa di malinconico in questa visione. Significa che l’Universo potrebbe essere pieno di civiltà, ma tutte tristemente isolate, incapaci di superare le distanze siderali che le separano. Come tanti naufraghi su isole diverse, che si vedono a malapena all’orizzonte ma non riescono mai a raggiungersi.
Le critiche: forse siamo troppo pessimisti
Ovviamente, non tutti sono d’accordo con Corbet. Lo studio deve ancora passare attraverso la revisione paritaria (peer review), e molti scienziati hanno già sollevato obiezioni.
La critica principale? Stiamo proiettando la nostra specifica esperienza umana su tutte le possibili civiltà dell’Universo. È quello che in filosofia si chiama “antropocentrismo”: l’errore di pensare che tutti ragionino e si comportino come noi.

Pensa a quanto siamo diversi noi umani tra di noi. Ci sono culture che hanno dato priorità all’esplorazione e alla conquista, altre che hanno preferito la contemplazione e l’armonia con la natura. Alcune civiltà hanno sperimentato periodi di straordinario progresso tecnologico, altre hanno vissuto secoli di stagnazione. E stiamo parlando di una singola specie sullo stesso pianeta!
Ora estrapola questo concetto a livello cosmico. Gli alieni potrebbero essere fondamentalmente diversi da noi in modi che non riusciamo nemmeno a immaginare. Potrebbero non annoiarsi mai, o al contrario potrebbero non avere proprio il concetto di curiosità. Potrebbero vivere milioni di anni, rendendo i progetti a lungo termine perfettamente sensati. Potrebbero avere psicologie, motivazioni, priorità completamente aliene (letteralmente).
Inoltre, anche se il plateau tecnologico fosse reale, chi dice che tutte le civiltà si fermino allo stesso livello? Forse il nostro “soffitto” tecnologico corrisponde al loro “pavimento”. Potrebbero essere solo un gradino sopra di noi, quel tanto che basta per rendere possibili cose che noi consideriamo fantascientifiche, tipo viaggi interstellari come quelli in treno o comunicazioni istantanee attraverso chissà quale principio fisico che ancora non abbiamo scoperto.

E poi c’è l’argomento statistico: anche se il 99% delle civiltà si stancasse e smettesse di cercare, basterebbe quell’1% di ostinati o di fanatici dell’esplorazione spaziale per riempire la galassia di segnali e sonde. Come con tanti aspetti della vita, sono spesso gli outlier, gli eccentrici, quelli che non si arrendono mai, a fare la differenza.
E se invece avessimo torto su tutto?
C’è un’altra possibilità che vale la pena considerare: e se il nostro modo stesso di cercare gli alieni fosse completamente sbagliato?
Stiamo cercando segnali radio, tracce di megastrutture, indizi di attività tecnologica riconoscibile. Ma queste ricerche si basano su un assunto fondamentale: che le civiltà aliene comunichino e costruiscano cose in modi che noi possiamo riconoscere e comprendere.
Forse le civiltà avanzate hanno superato la fase “radio” milioni di anni fa e ora comunicano attraverso metodi che per noi sono completamente invisibili. Forse hanno capito come “vivere leggeri” a livello cosmico, minimizzando la loro impronta energetica invece di massimizzarla. Forse esistono in dimensioni o stati di realtà che la nostra fisica attuale non può nemmeno concepire.

Oppure, ancora più umiliante: forse ci stanno attivamente evitando perché ci considerano noiosi, pericolosi, o semplicemente non abbastanza interessanti. Come tu eviteresti di fermarti a parlare con un’ameba particolarmente aggressiva.
Cosa significa tutto questo per noi?
Indipendentemente da quale spiegazione del paradosso di Fermi si rivelerà corretta (se mai lo scopriremo), questo dibattito dice molto su di noi come specie.
La teoria della monotonia radicale di Corbet è essenzialmente uno specchio. Ci mostra i nostri limiti, le nostre frustrazioni, la nostra tendenza a entusiasmarci per grandi progetti per poi perdere interesse quando le difficoltà si fanno concrete. È una teoria che nasce dall’esperienza vissuta degli ultimi decenni, da quell’amarezza che proviamo quando guardiamo le audaci promesse del passato e le confrontiamo con la realtà più prosaica del presente.

Ma forse questo ci dice anche qualcosa di importante: che continuare a cercare, continuare a esplorare, continuare a spingersi oltre nonostante le difficoltà, è una scelta. Non è inevitabile che tutte le civiltà si stanchino e si fermino. Possiamo decidere di essere diversi.
Forse il vero messaggio della teoria di Corbet non è “gli alieni sono banali”, ma “non accontentiamoci di essere banali anche noi”. Se c’è anche solo una possibilità che il silenzio cosmico sia dovuto a una generale mancanza di perseveranza, allora possiamo scegliere di essere quella civiltà che non smette mai di cercare, quella che continua a mandare segnali e a tendere l’orecchio verso le stelle, decade dopo decade, secolo dopo secolo.
Il futuro della ricerca
Per fortuna, nonostante i budget limitati e le priorità che cambiano, la ricerca di vita extraterrestre continua. Progetti come il Breakthrough Listen stanno scandagliando il cielo con strumenti sempre più sensibili. I telescopi di nuova generazione, come il James Webb Space Telescope, stanno studiando le atmosfere di esopianeti alla ricerca di biosignature, quei segni chimici che potrebbero indicare la presenza di vita.
E chi lo sa? Magari tra dieci, cinquanta, cento anni riceveremo finalmente quel segnale che stavamo aspettando. O magari la nostra prima conferma di vita aliena arriverà in forma molto più umile: batteri su Marte, vita microbica sotto il ghiaccio di Europa, firme chimiche nell’atmosfera di un pianeta lontano.

Non sarà l’arrivo trionfale delle astronavi aliene nei film di fantascienza. Ma sarà comunque la risposta alla domanda più antica e profonda che ci siamo mai posti: siamo soli?
L’importanza di continuare a chiedersi: “Dove sono?”
Che la teoria della monotonia radicale sia corretta o meno, il paradosso di Fermi rimane uno degli enigmi più affascinanti che l’umanità si trova ad affrontare. Ci costringe a confrontarci con domande enormi sulla nostra natura, sul nostro destino, sul nostro posto nell’Universo.
Forse gli alieni sono là fuori, annoiati e stagnanti come ipotizza Corbet. Forse si sono autodistrutti. Forse ci stanno osservando. Forse non sono mai esistiti, e noi siamo davvero soli in questo angolo di cosmo. Oppure forse sono così diversi da noi che non riusciamo nemmeno a riconoscerli quando li vediamo.
La verità è che ancora non lo sappiamo. E forse è proprio questa incertezza, questa fondamentale ignoranza, a rendere la domanda così preziosa. Perché finché continuiamo a chiederci “Dove sono tutti?”, finché continuiamo a cercare, a esplorare, a spingerci oltre i nostri limiti, non importa quanto siamo “banali” o “monotoni”: rimaniamo una specie che guarda alle stelle con meraviglia.
E questo, amico mio, non è affatto banale.